
SISTEMA SAPI, MODULI MPL/MAPI, PL, MCO, MSS [1982-1984]
| SCHEDA PRODOTTO (on/off) |
|
COLLEZIONE MUDETO «–previous | next–» |

| SCHEDA PRODOTTO (on/off) |
|
COLLEZIONE MUDETO «–previous | next–» |
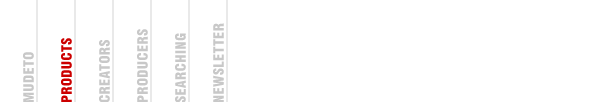
| AREA TEMATICA | Design per la Collettività | Design per l'Abitare |
| TIPOLOGIA | Sistema abitativo di pronto intervento per insediamenti provvisori |
| ANNO | 1982-1984 |
| PROGETTO | Pierluigi Spadolini |
| PRODUZIONE / PER | Edil.Pro. - Gruppo IRI-Italstat, Sicit - CE.ME.CO |
| RICONOSCIMENTI | XIV Compasso d'Oro ADI 1987 |
 Maria Cristina Tonelli (Roma 1951). Laureata in Storia dell'Arte presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Firenze nel 1976. Dal 1976 al 1981 ha usufruito di una borsa di studio per la specializzazione in Critica d'Arte presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove nel 1981, in seguito a concorso universitario, è diventata ricercatore universitario. Dal 1982 al 2002 ha proseguito la sua carriera universitaria presso la Facoltà di Architettura, prima come ricercatore, poi come professore associato di Industrial design. Dal primo novembre 2002 è professore ordinario di Industrial design presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. I suoi interessi scientifici sono rivolti alla storia dell'industrial design e, in particolare, all'analisi storico-critica del progetto e del prodotto industriale in relazione al suo tessuto storico, culturale, tecnologico, economico e produttivo. Si occupa anche di storia della moda, fra Ottocento e Novecento, e dei suoi problemi progettuali e produttivi in rapporto all'evoluzione della società, del mercato e del gusto. Ha collaborato con diverse riviste e ha scritto Il design in Italia 1925/1943 (Laterza, Roma-Bari, 1987), L'avventura dell'innovazione fra cultura materiale e strategia del progresso (Alinea, Firenze,1996) e Industrial design: latitudine e longitudine. Una prima lezione (Firenze University Press, Firenze, 2008).
[x]
Maria Cristina Tonelli (Roma 1951). Laureata in Storia dell'Arte presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Firenze nel 1976. Dal 1976 al 1981 ha usufruito di una borsa di studio per la specializzazione in Critica d'Arte presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove nel 1981, in seguito a concorso universitario, è diventata ricercatore universitario. Dal 1982 al 2002 ha proseguito la sua carriera universitaria presso la Facoltà di Architettura, prima come ricercatore, poi come professore associato di Industrial design. Dal primo novembre 2002 è professore ordinario di Industrial design presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. I suoi interessi scientifici sono rivolti alla storia dell'industrial design e, in particolare, all'analisi storico-critica del progetto e del prodotto industriale in relazione al suo tessuto storico, culturale, tecnologico, economico e produttivo. Si occupa anche di storia della moda, fra Ottocento e Novecento, e dei suoi problemi progettuali e produttivi in rapporto all'evoluzione della società, del mercato e del gusto. Ha collaborato con diverse riviste e ha scritto Il design in Italia 1925/1943 (Laterza, Roma-Bari, 1987), L'avventura dell'innovazione fra cultura materiale e strategia del progresso (Alinea, Firenze,1996) e Industrial design: latitudine e longitudine. Una prima lezione (Firenze University Press, Firenze, 2008).
[x]

















































| On/Off | Riferimenti Bibliografici |
| 2018 | Simona Canepa, Living mobile for emergency: lessons from big architects, in Marco Vaudetti, Valeria Minucciani, Simona Canepa, Nilufer Saglar Onay (a cura di), Suspended Living in Temporary Space. Emergencies in the Mediterranean Region. International Conference Proceedings. 9 October 2017. Politecnico di Torino, Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa |
| 2010 | Sintesi di tesi di laurea. Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria. Dall’abitazione temporanea all’edificio: innovazione e modularità di un sistema abitativo contemporaneo. Autore: Cecilia Paccheri. Relatori Prof. Ing. Ettore Guglielmi, Prof. Ing. Gloria Terenzi, Ing. Lorenzo Mattioli. Data di laurea: Luglio 2009, in “bollettino ingegneri”, n.8/9, 2010 |
| 2005 | Giampaolo Lavaggi, L’alloggio provvisorio per l’emergenza. L’evoluzione storica, dal 1940 ad oggi: ricerca, progetti, prodotti, in Donatella Mazzoleni, Marichela Sepe, Rischio sismico, paesaggio, architettura: l'Irpinia, contributi per un progetto, Università degli studi di Napoli Federico II - CRdC-AMRA, Ed. Alinea, Napoli |
| 2003 | Eleonora Trivellin, Abitare on the road, Ed. Alinea, Firenze |
| 2000 | Carmine Carlo Falasca, Architetture ad assetto variabile, Ed. Alinea, Firenze |
| 1998 | Giuseppe Chigiotti, Pierluigi Spadolini. Il design, Firenze,, Edizioni Cadmo, Fiesole - Firenze |
| 1998 | Eleonora Trivellin, Storia della tecnica edilizia in Italia: dall’unità ad oggi, Ed. Alinea, Firenze |
| 1993 | Maurizio Vitta, Pierluigi Spadolini e Associati. Architetture 1953-1993, l’Arca Edizioni, Milano |
| 1988 | Francesco Gurrieri (cura di), Pierluigi Spadolini. Umanesimo e tecnologia, Electa, Milano |
| 1988 | Corrado Latina, Sistemi abitativi per insediamenti provvisori, BE-MA editrice, Milano |
| 1985 | Giovanni Klaus Koenig, Pier Angelo Cetica, Francesco Gurrieri, Pierluigi Spadolini. Architettura e sistema. Otto opere in mostra ad Agliana. Giugno 1985, s.n.t. |
| 001 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 002 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 003 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 004 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 005 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 006 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 007 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 008 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 009 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 010 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 011 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 012 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 013 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 014 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 015 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 016 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 017 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 018 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 019 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat, courtesy Archivio Masssimo Polidori (ArchitettiRoma.it) |
 |
|
| 020 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 021 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © & courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 022 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 023 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 024 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 025 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 026 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 027 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 028 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 029 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 030 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 031 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 032 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 033 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 034 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 035 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 036 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 037 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 038 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 039 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 040 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 041 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 042 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 043 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 044 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 045 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 046 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 047 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 048 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 049 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 050 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 051 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 052 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 053 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 054 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 055 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 056 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 057 | Pierluigi Spadolini, SAPI - Sistema Abitativo di Pronto Intervento: MPL - Modulo (Base) Pluriuso; MAPI - Modulo Abitativo di Pronto Intervento; PL - Elemento (Modulo) Pluriuso di Connessione; MCO - Modulo (di) Connettivo; MSS - Modulo Semovente di Servizio, 1982-‘84, Edil.Pro. (1978) Gruppo IRI-Italstat - Roma | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat / Sicit - CE.ME.CO, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 058 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 059 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 060 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Da destra: l'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, Vincenzo Scotti (4 agosto 1983 –
26 marzo 1984), il suo immediato successore, Giuseppe Zamberletti e Pierluigi Spadolini | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 061 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Ancora a destra di Pierluigi Spadolini (al centro) sono riconoscibili sia il futuro Ministro per il coordinamento della protezione civile Giuseppe Zamberletti che il Ministro carica, Vincenzo Scotti (4 agosto 1983 – 26 marzo 1984) | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 062 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Il Modulo MPL/MAPI installato all'interno della manifestazione espositiva | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 063 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Da sinistra: Giuseppe Zamberletti e Pierluigi Spadolini, all'interno del Modulo installato mentre illustrano il progetto all'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, Vincenzo Scotti (4 agosto 1983 – 26 marzo 1984) | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 064 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | All'interno del Modulo installato Pierluigi Spadolini mentre illustra il progetto a Vincenzo Scotti, Ministro per il coordinamento della protezione civile dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984 | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 065 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Ancora all'interno del Modulo installato Pierluigi Spadolini a colloquio col Ministro per il coordinamento della protezione civile Vincenzo Scotti (4 agosto 1983 al 26 marzo 1984) | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 066 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Il Modulo MPL/MAPI installato all'interno della manifestazione espositiva e (al centro) il suo autore, Pierluigi Spadolini | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 067 | Aeritalia. Progetto Protex 84 per la Protezione civile - presentazione ufficiale del Sistema Abitativo di Pronto Intervento SAPI, Roma, 1984 | Sulla destra Pierluigi Spadolini con Gillo Dorfles | © Archivio Eredi Pierluigi Spadolini, courtesy Alberto Di Cintio |
 |
|
| 068 | Alcune immagini delle riprese del filmato (per la regia di Alessandro Cane) che racconta le fasi dell'installazione del prototipo del modulo abitativo MAPI approntato dall'azienda milanese IPI System (1961-1992) esperta in prefabbricati leggeri, 1983 ca. | © & courtesy Archivio Massimo Ruffilli |

 |
|
| 069 | Una fase dell'installazione in loco dei 196 moduli abitativi del Villaggio Italia completato a Spitak (Armenia) nel 1990 (a sinistra); Assonometria del progetto di urbanizzazione (a destra) | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat (Arca Edizioni), courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 070 | Vista parziale dei 196 moduli abitativi del Villaggio Italia installato a Spitak (Armenia) nel 1990 | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 071 | Una fase dell'installazione in loco dei 196 moduli abitativi del Villaggio Italia realizzato a Spitak (Armenia) nel 1990 | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 072 | Vista di una fase finale dell'installazione in loco dei 196 moduli abitativi del Villaggio Italia completato a Spitak (Armenia) nel 1990 (a sinistra); Assonometria del progetto di urbanizzazione (a destra) | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat (Arca Edizioni), courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 073 | Un altro momento dell'installazione in loco dei 196 moduli abitativi del Villaggio Italia completato a Spitak (Armenia) nel 1990 | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat, courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 074 | Veduta aerea del Villaggio Italia realizzato a Spitak (Armenia) nel 1990 | © Edil.Pro. Gruppo IRI-Italstat (Arca Edizioni), courtesy Archivio Eredi Pierluigi Spadolini |
 |
|
| 075 | Vista d'all'alto del Villaggio Italia tuttora operante attualmente a Spitak (Armenia), 2020 | © & courtesy Depiver.com |
 |
|
| 076 | Veduta d'insieme dall'alto del Villaggio Italia tuttora operante attualmente a Spitak (Armenia), 2020 | © & courtesy Depiver.com |
 |
|
| 077 | Una immagine, risalente al 2020, dell'area d'insediamento del Villaggio Italia a Spitak in Armenia avvenuta tra 1989 e il 1990 | Come si può notare, dopo oltre 30 anni le abitazioni temporanee di costruzione italiana sono tuttora operative (gli interventi più appariscenti attuati nel corso del tempo nei riguardi dei moduli hanno coinvolto le coperture) | © & courtesy Stories Beyond The Ruins |
 |
|
| 078 | Un'ulteriore immagine dell'area d'insediamento del Villaggio Italia a Spitak in Armenia (avvenuta tra 1989 e il 1990) con una vista più dettagliata del più vistoso intervento, attuato presumibilmente dagli stessi utenti, sulle coperture delle abitazioni temporanee, 2020 | © & courtesy Depiver.com |
 |
|
| 079 | Veduta dell'interno dell'area d'insediamento del Villaggio Italia a Spitak in Armenia, 2020 | © & courtesy Urbanista |
 |
|
| 080 | A destra: una immagine tratta delle riprese del filmato (per la regia di Alessandro Cane) che racconta le fasi dell'installazione del prototipo del modulo abitativo MAPI approntato dall'azienda milanese IPI System (1961-1992) esperta in prefabbricati leggeri, 1983 ca. / Faces of Armenia A sinistra: una immagine recente del Villaggio Italia a Spitak, 2020 ca. | © & courtesy Archivio Massimo RuffilliPierluigi Spadolini (a dx) / © & courtesy Faces of Armenia |
 |








|
||
| 1932-‘00 | name: | Pierluigi Spadolini |

|
||
| 1978 | name: | Edil.Pro. - Gruppo IRI-Italstat |

|
||
| 1967 | name: | Sicit - CE.ME.CO |

|
|
| 1987 | XIV Compasso d'Oro ADI - Milano |

|
I maestri dell’architettura e del design - Pierluigi Spadolini Regia: A. Di Cintio / Soggetto e Sceneggiatura: A. Di Cintio, E. Segoni / Riprese: A. Cerbai, G. Savi, G. Fergus Miconi / Montaggio: G. Melis / Ottimizzazione fonti iconografiche: G. Savi, A. Comparini / Musica originale: K. MacLeod - Meditation Improptu 03 |
| 2016 | © video: Università degli Studi di Firenze |
| 2018 | Simona Canepa, Living mobile for emergency: lessons from big architects, in Marco Vaudetti, Valeria Minucciani, Simona Canepa, Nilufer Saglar Onay (a cura di), Suspended Living in Temporary Space. Emergencies in the Mediterranean Region. International Conference Proceedings. 9 October 2017. Politecnico di Torino, Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa |
| 2010 | Sintesi di tesi di laurea. Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria. Dall’abitazione temporanea all’edificio: innovazione e modularità di un sistema abitativo contemporaneo. Autore: Cecilia Paccheri. Relatori Prof. Ing. Ettore Guglielmi, Prof. Ing. Gloria Terenzi, Ing. Lorenzo Mattioli. Data di laurea: Luglio 2009, in “bollettino ingegneri”, n.8/9, 2010 |
| 2005 | Giampaolo Lavaggi, L’alloggio provvisorio per l’emergenza. L’evoluzione storica, dal 1940 ad oggi: ricerca, progetti, prodotti, in Donatella Mazzoleni, Marichela Sepe, Rischio sismico, paesaggio, architettura: l'Irpinia, contributi per un progetto, Università degli studi di Napoli Federico II - CRdC-AMRA, Ed. Alinea, Napoli |
| 2003 | Eleonora Trivellin, Abitare on the road, Ed. Alinea, Firenze |
| 2002 | Centro MAAS, Introduzione all'archivio storico dell'IRI, 5 giugno |
| 2000 | Carmine Carlo Falasca, Architetture ad assetto variabile, Ed. Alinea, Firenze |
| 1998 | Giuseppe Chigiotti, Pierluigi Spadolini. Il design, Firenze,, Edizioni Cadmo, Fiesole - Firenze |
| 1998 | Eleonora Trivellin, Storia della tecnica edilizia in Italia: dall’unità ad oggi, Ed. Alinea, Firenze |
| 1994 | Massimo Canfailla, Athony Lee, Eugenio Martera, Pierpaolo Perra, Architetture del mare. La progettazione nella nautica da diporto in Italia, Alinea - Firenze |
| 1993 | Maurizio Vitta, Pierluigi Spadolini e Associati. Architetture 1953-1993, l’Arca Edizioni, Milano |
| 1988 | Francesco Gurrieri (cura di), Pierluigi Spadolini. Umanesimo e tecnologia, Electa, Milano |
| 1988 | Corrado Latina, Sistemi abitativi per insediamenti provvisori, BE-MA editrice, Milano |
| 1985 | Giovanni Klaus Koenig, Pier Angiolo Cetica, Francesco Gurrieri (a cura di), Pierluigi Spadolini. Architettura e sistema. Otto opere in mostra ad Agliana. Giugno 1985, s.n.t. |
| ... | Moduli Abitativi
Pronto Impiego - brochure CE.ME.CO, s.d. |
| ... | SAPI Sistema Abitativo di Pronto Impiego - brochure Sicit, s.d. |
